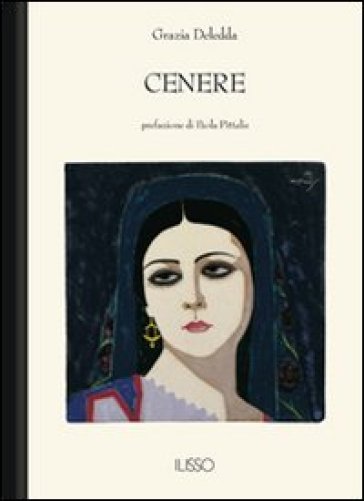Chiuso e consultabile sul blog dedicato all’iniziativa
(feminismfieraeditoriadelledonne.wordpress.com) il programma completo
della prima fiera dell’editoria delle donne che si terrà a Roma da
giovedì 8 a domenica 11 marzo. «Feminism», così il nome scelto che
colloca l’iniziativa in un solco preciso, si svolgerà alla Casa
internazionale delle donne; ospiterà 70 stand di case editrici
rappresentative di una produzione culturale contemporanea tra le più
vitali dell’editoria italiana e internazionale.
Non solo attente (e più numerose) lettrici infatti, secondo i recenti dati sul «consumo» di libri, ma anche prolifiche, da decenni, osservatrici della realtà che raccontano una esperienza di decenni alle spalle; lavorando nell’officina della scrittura a tutti i livelli della filiera editoriale.
Promossa, ideata e organizzata da Archivia, Leggendaria, Casa Internazionale delle donne e Sessismoerazzismo, con il sostegno di Odei (Osservatorio degli Editori Indipendenti) e Iacobellieditore, «Feminism» darà spazio a direttore di case editrici, collane, librerie, biblioteche e traduttrici.
Insieme a una mostra documentaria (promossa e curata da Archivia sull’editoria del secolo scorso), l’intento – si legge nel breve comunicato stampa – è quello di «mettere in evidenza, attraverso dei Focus, tutti i passaggi della Filiera del libro d’Autrice: le scelte editoriali, la stesura del testo, la produzione, la promozione, la distribuzione e l’attività critica e divulgativa di testate specifiche, sia cartacee che on-line». Il filo conduttore sarà quello della discussione, della testimonianza e soprattutto dell’esperienza che si costella anche in Italia di punti storici precisi e di novità.
Non solo attente (e più numerose) lettrici infatti, secondo i recenti dati sul «consumo» di libri, ma anche prolifiche, da decenni, osservatrici della realtà che raccontano una esperienza di decenni alle spalle; lavorando nell’officina della scrittura a tutti i livelli della filiera editoriale.
Promossa, ideata e organizzata da Archivia, Leggendaria, Casa Internazionale delle donne e Sessismoerazzismo, con il sostegno di Odei (Osservatorio degli Editori Indipendenti) e Iacobellieditore, «Feminism» darà spazio a direttore di case editrici, collane, librerie, biblioteche e traduttrici.
Insieme a una mostra documentaria (promossa e curata da Archivia sull’editoria del secolo scorso), l’intento – si legge nel breve comunicato stampa – è quello di «mettere in evidenza, attraverso dei Focus, tutti i passaggi della Filiera del libro d’Autrice: le scelte editoriali, la stesura del testo, la produzione, la promozione, la distribuzione e l’attività critica e divulgativa di testate specifiche, sia cartacee che on-line». Il filo conduttore sarà quello della discussione, della testimonianza e soprattutto dell’esperienza che si costella anche in Italia di punti storici precisi e di novità.